La serpe in seno
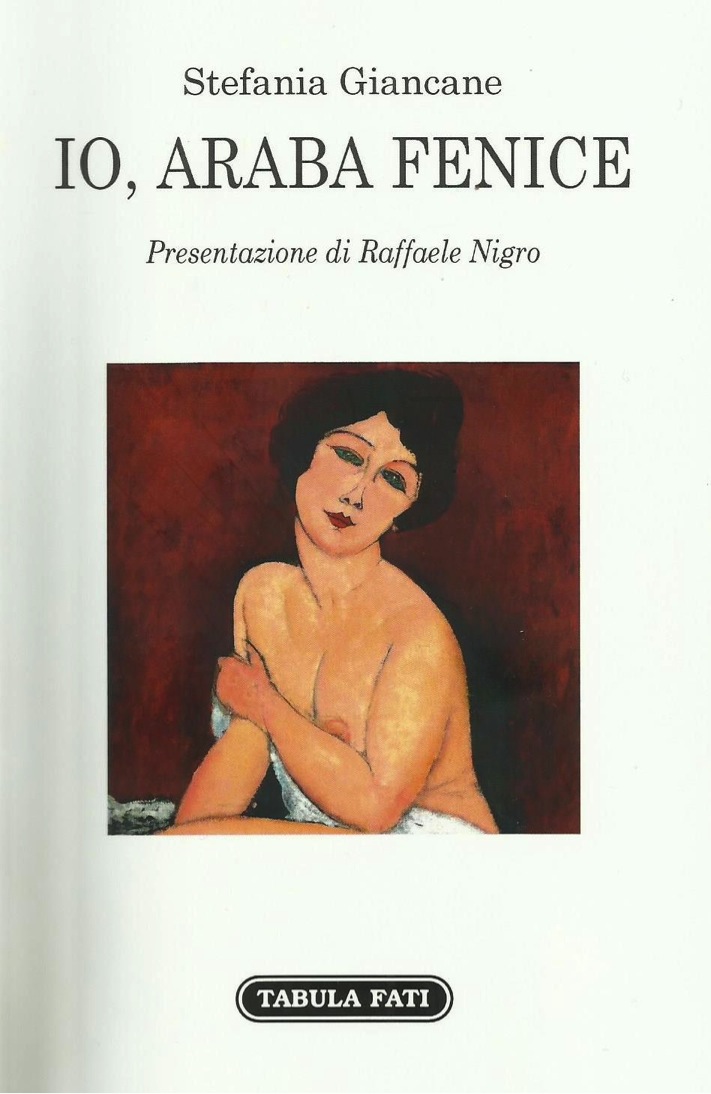
Una giovane donna scopre quasi per caso d’avere un brutto male e da un giorno all’altro la sua vita va incontro a uno scarto improvviso, parte per la tangente, imbocca una discesa vertiginosa. Scalzata brutalmente dalla placidità rassicurante del proprio quotidiano, Stefania si ritrova come sbattuta al fronte, in prima linea, in trincea, col Nemico che preme dall’altra parte e con la consegna di resistere a qualunque costo. Ed è subito guerra. Negli intervalli fra un bombardamento e un assalto all’arma bianca, l’innocente riflette sulla propria condizione e su quella delle compagne di sventura. Lo fa riempiendo pagine di un taccuino, un altro diario di guerra. Così, ‘Io, araba fenice’ di Stefania Giancane (Tabula Fati, 2017). Un diario composto da quarantacinque brevi capitoli, fitti d’un periodare sempre lucido, secco e puntiglioso dove le cose sono chiamate per nome, senza perifrasi o inutili pudori. Qua e là si aprono scorci d’intensa poesia, altrove scalpita un’ironia pungente. E una bimba smarrita ma ancora capace di stupirsi del creato alterna la sua voce a quella di una donna precocemente temprata ma non inaridita, che più attenta e curiosa di prima osserva, riflette turbinosamente, sfodera gli artigli e si riscopre guerriera. Da fronteggiare è una coalizione di paure impegnate in una danza macabra intorno alla paura primaria. C’è qualcosa di peggio della paura della paura? In un centinaio di agili pagine si asciugano poco meno di due anni di conflitto (15 ottobre 2012 – 16 luglio 2014). Due anni che valgono venti. L’armistizio trova la povera soldatessa vittoriosa, benché segnata nella carne dai dardi di “una fortuna oltraggiosa” (Amleto). Miracolo di una medicina sofisticatissima – anche sottilmente minacciosa – e di una straordinaria prova di reattività (“prendere le armi contro una mare d’affanni e, opponendosi, por loro fine…” – ancora lui, il Principe di Danimarca). Un diario, dicevamo. Ma pure un manuale di combattimento. Stefania Giancane si guarda attorno e la vastità del dramma che l’avvolge (sono impressionanti certi numeri) opportunamente le riporta alla mente la pestilenza descritta dal Manzoni. Eppure, per il senso accorato del cameratismo, ‘Io, araba fenice’ richiama, e forse meglio, altra opera, ‘Padiglione Cancro’ di Solženicyn. Un calvario senza crocifissione in cui persino la solidarietà delle altre donne colpite dallo stesso male non basta. Perché quella del malato è condizione crudele. Hai un bel giocare in casa con le curve ribollenti di ultras appassionatissimi (genitori e fratelli impagabili e qualche amico di sicuro affidamento), però alla fine sul prato scendi in solitudine. E quello, l’Avversario, è uno che si fa un baffo del fattore campo.
Italo Interesse
Pubblicato il 3 Ottobre 2017



